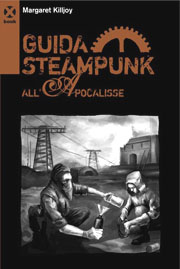Quest’estate Sara e Livia si sono presentate un giorno da ADA Lab armate di blocchetti di appunti e registratore. Mentre preparavo un dolce di susine per la cena freegan abbiamo fatto una lunga chiacchierata che si è trasformata in un’intervista uscita pochi giorni fa su Diotima.
Qui trovate il PDF, ed ecco il testo completo:
Sara Bigardi e Livia Alga 
conversazione con reginazabo
Apocalypse wow:
www.ada-lab.it ovvero via Framarin 42, Vicenza
“ADA è un acronimo. Ognuno può scegliere come interpretarlo. A me un po’ di parole già vengono in mente: autogestione e autoproduzione, antisessismo, antirazzismo, arrembaggio e anarchia per la A, decrescita e do-it-yourself, disordine, dissenso, détournement e diversità per la D. Ma ce ne sono molte altre: ADA Lab aspetta i suggerimenti di chiunque gliene vorrà dare”
www.reginazabo.noblogs.org
Non eravamo mai state insieme a Vicenza, e la prima volta ci siamo perse. Pioveva ininterrottamente, nessuno sapeva indicarci Viale del Sole, la tangenziale che ci avrebbe portate vicine alla meta. Poche persone per strada, era domenica, appunto ad ADA Lab era la domenica queer. Magicamente ci ritrovammo di fronte l’Auchan, come doveva accadere secondo le poche istruzioni copiate in fretta da Internet; si parlava anche di un parcheggio e, rassegnate sotto uno dei pochi alberi allineati tra l’asfalto, ad un certo punto stavamo per decidere di essere arrivate. Tutto grigio intorno, capannoni, centri commerciali e lunch bar, ADA Lab non poteva essere lì, in mezzo ad uno scenario così ordinario. Livia era già sul punto di lamentarsi della desolazione del paesaggio. Le aspettative erano altissime: Sara aveva rinunciato a scrivere la cronaca della partita Monza-Viareggio, Samar aveva sfidato la viscerale paura del terremoto della notte prima. In un modo o nell’altro, ci aspettavamo che ADA Lab ci salvasse dalle nostre varie ansie esistenziali-ambientali del momento. Nei nostri immaginari aveva tutte le carte in regola per farlo.
Per quanto potessimo saperne senza esserci ancora state, ci sembrava corrispondesse infatti alla realizzazione di un progetto tante volte evocato tra noi (un ‘noi’ riferito non solo alle presenti andate in avanscoperta): arginare la dispersione della nostre vite diasporiche scegliendo finalmente una città da abitare insieme, investire in una casa e farne un luogo femminista di eco-autoproduzioni editoriali, artistiche, tecnologiche ed artigianali. Sarà anche per questo suo carattere di aderire ad un desiderio condiviso che ADA Lab in pochi mesi era diventato uno dei riferimenti nella mappa dei luoghi femministi da conoscere in Europa. La notizia dell’apertura era rimbalzata da un punto all’altro della rete: noi a Verona l’avevamo saputo da Jordana e Kiara a Valencia, che l’avevano saputo dalla Fra di Pisa quando, da Madrid, era andata a trovarle.
Varcato il cancello di ADA Lab, costruito con telai e pezzi di biciclette, sembrava di avere viaggiato davvero.
Ci accoglie reginazabo; è primavera ma fa ancora freddo, ci offre un tè caldo. Lunghi dread biondi raccolti, occhi verdi, reginazabo è di Napoli e a Vicenza è arrivata per amore: devo dire che la dimensione della cittadina mi sta meglio della città grande, per quanto il mio cuore sia in determinate città grandi. Le volte che ho provato a viverci, l’ho sempre trovato molto stressante. Le città grandi ti chiedono di lavorare per vivere, mentre in quelle piccole riesci anche a trovare un posto per abitare a un prezzo ragionevole: a Vicenza posso lavorare part-time e seguire dei progetti, a Roma no. In genere, ho molta difficoltà a trovare una dimensione mia; per esempio a Roma l’avevo trovata, però quando stavo per andarmene; ci tornerei che ne so, se vincessi la lotteria e potessi permettermi di non vivere in periferia. Ho vissuto in varie città d’Italia, anche in Germania. Di solito mi sono spostata soprattutto seguendo corsi di studio, però sempre, in verità, perché avevo bisogno di cambiare aria.
Mentre racconta dei suoi vari spostamenti reginazabo prepara lo zucchero di canna e la farina biologica per fare un crumble di susine gialle. Scorre la ricetta sul suo smartphone. Il piano di lavoro è fatto di mattonelle dipinte di un altro tempo. Vengono dalla casa di sua madre, a Napoli, che ha dovuto dismettere; l’alternativa era buttare via tutto o portare il più possibile con sé. La credenza laccata di bianco, il mobile al centro della cucina, le mattonelle del balcone: ha traslocato a Vicenza con un camion. A Napoli da adulta non sono mai riuscita a vivere, ci ho provato, due volte, ma non è proprio la mia dimensione, non lo è mai stata. Me lo dicevano anche quando avevo sedici anni che non ero napoletana.
Sentirsi straniere nel proprio contesto d’origine può essere un guadagno, una leva salvifica.
Mio padre è originario di Napoli, mia mamma della provincia. Anche mio padre era un po’ straniero, infatti anche lui non vive più a Napoli. Sono stata educata all’essere straniera in terra napoletana, mi hanno dato dei valori che non combaciavano necessariamente con la napoletanità. Per esempio, la non aggressività, per esempio l’onestà; è difficile da spiegare, poi si ricade in poche parole nelle generalizzazioni stereotipate, però a Napoli io trovo che ci sia sempre un rapporto di forte violenza, bisogna imporsi. Da quando giri per strada e i maschi ti urlano dietro, fin da ragazzina, ai rapporti quotidiani. È molto più violento che qui.
Ascoltando reginazabo, a Sara vengono in mente le atmosfere dei romanzi di Elena Ferrante1, dove Napoli viene osservata al microscopio, isolata nei suoi frammenti, per emergere come sintesi di emozioni contrastanti da interrogare.
Sara non ha mai vissuto a Napoli, eppure sente di capire cosa intende reginazabo quando parla della sensazione di estraneità rispetto al proprio contesto d’origine. Per lei significa non volere pienamente radicarsi nel nord-est natio delle cui infelici contraddizioni è consapevole.
Livia, intanto, ripassa dentro di sé: andarsene via da una città del sud, il senso di impossibilità di riconoscervisi, i brutti ricordi. L’idea nutriente di un non ritorno, i ritorni che deludono, i ritorni che ti fanno ritrovare, la voglia ostinata di moltiplicare i ritorni, la forza dell’origine, le visioni nuove, passaggi benefici, le illusioni. Il desiderio di portare il più possibile, il buono, ovunque con sé. L’intuizione: non potevi che partire.
“Viaggiare tonifica glutei e cervello”
All’ingresso di ADA Lab, l’immagine di una donna vittoriana sul volantino di Betty&Books2 dispensa i suoi messaggi dal XIX secolo. Icone di viaggiatrici e avventuriere, quando ancora non era norma delle donne middle-class bianche spostarsi senza essere le accompagnatrici di qualcuno, le victorian ladies3 hanno vissuto anche un tempo di profondi cambiamenti nella concezione dei piaceri e dei saperi sui corpi. E dallo stesso volantino ce ne parlano con ironia:
“ Il vibratore risale al 1800, il dildo a mooolto prima”4
“Le palline vaginali rafforzano il pavimento pelvico”
Firmato Betty&Books: un’associazione culturale bolognese che nasce dal desiderio di lavorare sull’immaginario del corpo e della sessualità, in una prospettiva che crei una connessione con le varie forme d’arte, in un’ottica di genere. Da ADA Lab durante una domenica queer di aprile, Betty&Books ha tenuto un workshop sui sextoys – di cui il flyer era l’invito – e ne ha lasciato una invitante fornitura, disponibile alla vendita, nell’armadietto del salone: il secret shop, che compare e scompare a seconda del pubblico presente.
Chi è questa victorian lady traveller che ci consiglia dal volantino di provarne uno?
All’inizio Livia pensava fosse Ada Byron: la donna che dà il nome alla casa e alla scommessa politica di reginazabo. “ADA (Lab) è per Ada Byron5, la prima persona che abbia mai scritto, a metà del XIX secolo, un algoritmo per una macchina: la macchina analitica ideata da Charles Babbage, il difference engine, che ha dato il titolo a uno dei pilastri dello steampunk, The Difference Engine di Gibson e Sterling, in italiano La macchina della realtà, un libro in cui tra i personaggi c’è anche Ada.
In effetti ancor prima che avesse un nome o una forma, ADA Lab è nata nella mia testa come luogo steampunk, e a chi intitolare un laboratorio steampunk se non a Ada Byron, a questa programmatrice, a questa signora vestita di crinoline che parlava con una macchina di legno e ottone che nella sua vita non vide mai realizzata?” (da qui)
reginazabo ci guarda con aria interrogativa per capire se “steampunk” ci rimandi ad altro se non all’insignificante traduzione letterale “vapore punk”. Steampunk? Cyberpunk? Sapete cosa sono? No, assolutamente no. Poi vi do una copia della Guida steampunk all’apocalisse di Margaret Killjoy. Queste sono proprio le mie ispirazioni principali. Inizio a dedicarmi alle questioni di Internet negli anni ’90, e resto affascinata da alcune potenzialità della rete. Vi ricordate il famoso fumetto del cane davanti a Internet? “Su Internet nessuno sa che sei un cane”. Soprattutto negli anni ’90 potevi dire che eri un marziano. C’era la cultura di inventarsi delle identità altre, un luogo alternativo, un iperspazio. Questo si riconduce alla filosofia cyberpunk, che nasce dalla letteratura fantascientifica: vivere mondi virtuali in realtà alternative. A me piaceva parecchio questa possibilità soprattutto collegata al post femminismo, in particolare all’elaborazione di Donna Haraway sull’identità mediata dalla rete. L’avevo trovata interessante come spunto, come fascinazione. E mi sono avvicinata sempre di più al mediattivismo.
reginazabo perde di vista Pixel, il cucciolo di cane da poco con loro, che sparisce sempre; teme stia scavando nel vaso del basilico o mangiando le foglie della pianta di zucca.
Livia: Pixel si chiama così non a caso.
Sara: Pixel, il più piccolo punto di un’immagine non visibile ad occhio nudo.
Non è a caso! Nel 2008 scopro lo steampunk, che come il cyberpunk, nasce come genere letterario, diventando poi un movimento. Lo steampunk nella letteratura è un cyberpunk ambientato in un Ottocento vittoriano già informatizzato e altamente sviluppato, o in una futura società improntata all’ordine ipertecnologico e alla cortesia vittoriana. A me piace moltissimo perché mi sembra sia quello che accade ora: tecnologia avanzatissima, morale vittoriana. Penso agli attacchi alla legge 194, per dirne una. Ho l’impressione che stiamo ritornando indietro, a prima degli anni ’60, agli anni ’50, come morale.
“Del mondo vittoriano la cultura steampunk rievoca non solo l’estetica sfarzosa e il contegno decoroso ma anche gli aneliti di rivolta, a partire dal luddismo e da celebri gesta anarchiche come il regicidio di Gaetano Bresci. Questo però non significa affatto che lo steampunk sia un movimento luddista o misoneista, e neanche che veda la ribellione diretta come missione inderogabile: piuttosto, nel rievocare quei percorsi di contrapposizione si ritorna con una punta di rimpianto a un’epoca ancora aperta a molte scelte possibili, a un periodo in cui l’idea di progresso si associava pur sempre all’utopia del benessere universale ed era opinione comune che tutti i popoli della terra potessero godere dei mirabili frutti dell’intelletto umano”6.
Tuttavia “i rimandi steampunk al fascino dell’estetica vittoriana non dissimulano in alcun modo il fetore dei vicoli delle città ottocentesche, il catarro dei tubercolotici,i massacri del colonialismo e la patina di carbone sul volto dei minatori bambini,(…) rammentandoci che se l’epoca vittoriana era solo l’inizio di un percorso, quel percorso sta ora giungendo a termine e, avvicinandosi al suo culmine, si sta scontrando con i suoi ovvi limiti, di natura fisica e geografica” (da qui).
Livia: Mi affascina questo discorso sulla fantascienza, non ne ho letta mai, è l’immaginazione di altri mondi possibili?
Sì, ogni tanto io scrivo fantascienza anche per creare delle alternative.
Che non vuol dire dimenticare la realtà o trasfigurarla per evaderla. Come scrive, infatti, Ursula Le Guin, una delle rappresentanti del filone fantascientifico femminista, “in un certo senso l’evasione c’è, ma quello da cui si evade è la banalità della narrativa popolare e di quasi tutto il cinema e la tv. Nessuno va a scovare il pensiero radicale in un settore che i critici bollano come genere d’evasione”7.
Penso che la fantascienza sia il genere che descrive meglio la realtà, soprattutto la realtà politica. Per descrivere la realtà c’è bisogno di metafore, per raccontare la verità c’è bisogno di metafore. Raccontare la verità così come è non è incisivo come raccontare la realtà attraverso le metafore.
Sara: Metafore non concettuali, immagino. Quelle vive, vitali, concrete. La metafora non concettuale diviene concezione della realtà. Per me la metafora è vera solo se concepisce la realtà, la partorisce, riscattandola, liberandone altri sensi, altri significati, altre rivelazioni. Questo dovrebbe mettere in atto il linguaggio metaforico: un riscatto del reale, per accoglierlo secondo un’altra radicalità.
Sì, è quello che sostengo io. Se tu vai a dire alla gente che il 90% delle persone detiene il 10% della ricchezza e il 10% delle persone hanno il 90% della ricchezza, le persone dopo un po’ si dimenticano i numeri, mentre se vai a descrivere un mondo simile al loro in cui non tutto è uguale, e gli fai vedere le conseguenze della situazione, in qualche modo saranno più toccate. Penso a 1984 di Orwell o a Il Mondo nuovo di Huxley, che sono due romanzi di fantapolitica. Quelli hanno influenzato più menti nel corso della storia di quanto non abbiano fatto un testo sul totalitarismo e un altro di sociologia sul mondo contemporaneo. Perché? Perché raccontano una storia in cui le persone si rispecchiano, però non fino in fondo, quindi poi hanno la possibilità di continuare a riflettere. Mentre se tu racconti la loro storia così com’è, probabilmente si sentiranno soddisfatte di quello che hanno letto e smetteranno di pensarci su.
reginazabo non è una scrittrice, ma quando scrive racconti, li scrive di fantascienza.
Partecipa al progetto “Collane di ruggine” che, come si legge nella presentazione della collana stessa, ha pubblicazioni aperiodiche “perché noi siamo discontinui, nessuno di noi è un professionista della scrittura e tutto ciò che leggete è rubato alla vita, al lavoro, al mondo tronfio che finirà in ruggine. Non siamo una casa editrice né un progetto editoriale nel senso classico del termine, non ci interessa guadagnare un centesimo dalla pubblicazione di questi testi e non abbiamo scelto l’editoria come unico mezzo di espressione. Troviamo delle cose che ci piacciono e ci mettiamo in moto per farle conoscere, semplicemente. Si tratta di sporcarsi le mani, di mettere in gioco cervello sangue e cuore senza rimanere lontani ad osservare futuri disegnati da altri”8. Il principio che sta alla base del progetto è quello dell’autoproduzione, del Do It Yourself9.
Nella cultura steampunk, infatti, un aspro attacco al mito del benessere insito nell’idea del progresso “si contamina con l’etica hacker e con il do-it-yourself punk, formulando una critica al progresso ipertecnologico e proponendo alternative autoprodotte e, soprattutto, aperte all’autogestione, per soddisfare i bisogni quotidiani di sopravvivenza ma anche di svago del mondo contemporaneo; un atteggiamento del genere è quello dello steampunk, che, ‘mettendo le mani dentro’ a computer e ad altri strumenti tecnologici per ammantarli di fascino rétro, sogna un mondo in cui le macchine siano fatte di ingranaggi e rotelle, molto più gestibili e manipolabili delle componenti quasi esoteriche e sicuramente imperscrutabili basate sul silicio e sui circuiti elettronici.
Nascono così macchinari e congegni sorprendenti e spettacolari che dietro le loro incantevoli spire di ferro battuto, gli inserti in mogano e le elaborate profilature in ottone celano computer portatili, mezzi di trasporto e strumenti musicali. (…) Un approccio che, rimandando a un’epoca in cui le macchine si potevano ancora costruire nel capanno degli attrezzi e chiunque poteva nel suo piccolo diventare un grande inventore, si spinge oltre il software libero per rivendicare un hardware open-source – la possibilità di manipolare gli strumenti tecnologici secondo le proprie esigenze e la propria idea di bellezza senza doverli sostituire per il minimo difetto”10.
Per esempio c’è un villaggio negli Stati Uniti, Open Source Ecology, dove hanno creato macchine ad hardware libero di cui mettono le istruzioni di costruzione online. Sono tanti moduli, e tu a partire da questi moduli puoi creare una ruspa, una zappa, una pressa per mattoni. Una delle cose che vorrei fare qui da ADA Lab, e che in realtà mi sta riuscendo poco, purtroppo, è proprio questa: fare dei workshop di creazione di cose, del lavoro sull’hardware libero e anche sul software libero. Finora abbiamo tenuto un corso introduttivo gratuito di Linux. Però mi piacerebbe che ci fosse qualcuno che ha voglia di sperimentare come costruirsi le cose. Il problema è che ci vogliono persone ‘nerdissime’, e il contesto è quello che è, non è facilissimo trovare delle persone tanto nerd in una città così piccola.
Mentre conversiamo, ad un certo punto, arriva una ragazza. Sarà per i discorsi che andiamo facendo, ma si fa presente come un’irruzione da un altro mondo. Parla un’altra lingua, viene dagli Stati Uniti, è un’ospite del bed & breakfast. Una parte di ADA Lab è infatti destinata ad accogliere turisti, giramondo, ciclisti. Un progetto di microimprenditoria. Il bed&breakfast mi permette di avere più tempo per riflettere, in questo modo posso lavorare un po’ di meno e dedicarmi a rimettere a posto una cosa oppure organizzare una serata. Mi serve come base.
ADA Lab è un luogo che si autosostiene, si autofinanzia. Nella cucina salone che ospita gli incontri si legge:
ADA Lab è uno spazio aperto ispirato all’etica del dono: tutte le sue iniziative sono non commerciali e chi la gestisce non ci guadagna se non in entusiasmo. ADA Lab non è però gratuita. Ci sono spese da sostenere, come l’elettricità, il riscaldamento e anche le bevande, il cibo che non riusciamo a recuperare. Costano, per questo lascia un contributo nella cassetta. I soldi verranno utilizzati per arricchire ADA Lab di nuovi strumenti e iniziative.
La logica del gratuito e del dono penso sia ormai l’unico modo per fare le cose. La casa è mia, l’ho comprata con un’eredità che mi è successo di ricevere. I soldi entrano, perché ti bastano poche donazioni per pagare le bollette. Bisogna trovare modi di fare le cose a basso costo; comprare la casa non è stato a basso costo, ma metterla a disposizione cosa mi costa? L’elettricità? Sì, però un terzo delle bollette si pagano con la cassetta. Nella cassetta qualche soldo entra sempre. Se tu fai capire alle persone che un progetto continua se si basa sulle loro donazioni, le persone te li donano i soldi. Se invece cominci a fare il discorso “devo guadagnare almeno duemila euro, altrimenti non ne esco”, alla fine devi alzare i prezzi, poi devi contare sul denaro pubblico, e diventa difficile. Invece se fai tutto a basso costo, le cose sono più facili.
Questo a prescindere dal fatto che i fondi statali mancano, perché anche se ci fossero, sarebbero dati a certe condizioni. Nel migliore dei casi a patto che il posto sia assolutamente a norma, nel peggiore, che attenui certe posizioni politiche, e in ogni modo, devi avere un budget elevato. Se ti impelaghi con i soldi pubblici sicuramente devi avere un’impresa, un progetto di impresa, un progetto di guadagno, un progetto di profitto. Anche il famoso ‘no profit’ non è veramente ‘no profit’, c’è sempre il bisogno di trovare un modo per avere entrate consistenti per poter essere a norma. Ecco a me questo non interessava, desideravo, invece, un altro no profit, a me interessa dimostrare che tutti possono fare cose piacevoli, sociali, di creazione di comunità, di critica della realtà, senza bisogno di fare impresa. Anche per questo, qui non c’è un’associazione, perché nel momento in cui crei un’associazione, il pubblico poi viene a controllare ciò che stai facendo. E sei punto a capo. Io l’ho visto: il Comune aveva dato ad un’associazione uno spazio enorme, bellissimo, però se lo sono dovuto rimettere tanto a posto che alla fine pensavano solo ai soldi. E se devi pensare solo ai soldi, non pensi ai contenuti. C’è poco da fare, quindi il pubblico non è solo una questione, secondo me, di mancanza di soldi, a parte il fatto che ora i soldi scarseggiano veramente. Sullo Stato non ci conto, è repressivo perché deve mantenere un certo status quo, non è mai un incentivo alla creazione, perché tenta di mantenerti dentro certi paletti e farti seguire un percorso capitalistico. Se vuoi creare un percorso non capitalistico devi escludere i fondi pubblici, ma anche quelli privati, devi insomma escludere i finanziamenti. Puoi andare solo a donazioni. Oppure occupare, credo che le occupazioni siano la cosa migliore. Perché non capita sempre di ricevere un’eredità, anzi, non capita mai.
Quando sono arrivata a Vicenza vivevo già certe insoddisfazioni politiche, ero portatrice di istanze che qui mancano completamente. I centri sociali di Vicenza o Padova fanno una politica secondo me ingenua, movimentista, d’impulso: i ragazzini si sfogano, i vecchi frenano, per cui alla fine non succede niente. Lasciano soltanto sfogare in maniera catartica delle rabbie, senza una strategia nel loro agire politico.
Quando sono arrivata stava cominciando il movimento No Dal Molin e molti mi hanno criticata per non averci partecipato. Ma benché mi riconoscessi nell’istanza dell’antimilitarismo, non mi riconoscevo nelle pratiche.
Mancavano un’autogestione e un’orizzontalità autentiche. Io all’epoca ero ancora in affitto in un appartamento di due stanze. Quando poi ho cominciato a riflettere su cosa fare dell’eredità ho pensato che ci stava bene un posto, ho cominciato a cercare una casa da comprare, e nel frattempo ho avuto l’occasione di affittare uno spazio di 100mq2 in un deposito dell’Ottocento, abbandonato, a 100 euro al mese. Era una situazione precaria perché era un luogo che doveva essere abbattuto per farci un centro dedicato alla mobilità, ovvero un parcheggio, credo. Non so bene cosa ne sarà, però me lo hanno affittato. Ho detto che era per fare l’ info shop, però quando me lo hanno dato, ho raccolto tutte le persone che potevano essere interessate ad avere uno spazio proprio. L’idea è piaciuta molto e infatti per sei mesi c’è stato questo posto che abbiamo chiamato “La Corte del deposito 95”, dove c’era sì il mio info shop, ma dove venivano anche organizzati concerti, i seminari su come autoprodursi i libri, le esposizioni di autoproduzioni. Agli eventi partecipavano 500 persone a volta. Andava benissimo, era fantastico. Lo spazio si trovava in centro, a dieci minuti di cammino da Piazza dei Signori. Solo che, appunto, abbiamo avuto troppo successo, avevamo un messaggio troppo politico evidentemente, e i proprietari si sono agitati: ce l’avevano affittato da gennaio a giugno, ma ad aprile sono venuti a dirci che se ce ne andavamo prima loro erano più contenti. Ma poiché l’ultima festa prevista per giugno era già stata organizzata, siamo rimasti fino all’inizio dell’estate. E poi ce ne siamo andati. Quando il posto non c’è stato più, non ci sono state le energie per trovarne uno più caro, o insomma per continuare l’esperimento. Perciò si è tutto interrotto, e qui stiamo parlando del giugno del 2010.
Quando l’esperienza della Corte è finita, uno dei motivi che hanno bloccato la questione era il seguente fatto: io alla Corte avevo detto: “Bene, con 100 euro al mese tutti quanti possono usarla, però, possono usarla soltanto, attenzione, se non si tratta di iniziative fasciste, sessiste, razziste”. Questo è andato bene alla Corte, ma quando poi c’era un altro posto che eventualmente poteva ospitare le nostre attività, questa cosa dell’antifascismo è stata messa in discussione.
Livia: In che termini?
Nei termini di buonismo nei confronti di tutti, anche perché Vicenza è piccola, e quindi tutti sono amici di tutti. E molti anche amici di fascisti. Poi qui non ci sono i fascisti di Verona, che fanno paura, non c’è la gente che ti picchia o ti uccide, per fortuna. Per cui capisco che si riesca a mantenere questo rapporto di acqua calma e paludosa in tutta la città, però c’è acqua calma e paludosa proprio per questo fatto che tutti sono amici di tutti, e nessuno riesce a sollevare conflitti di nessun tipo. Per questo non si fa politica. Per cui non puoi aprire un discorso politico un po’ diverso da quello che già c’è, perché altrimenti entri in conflitto con degli amici. Se ci sono dei problemi vengono anche sollevati, però poi non li risolvono; a Vicenza funziona che quando c’è un problema smettono di parlarsi. Per cui non si affronta il conflitto.
Sara: Emerge qui, con il fatto che “tutti sono amici di tutti”, una giustificazione di certi atteggiamenti. Se non c’è una presa di posizione, una messa in discussione di certi comportamenti, di certe idee, di certe ideologie, oltre a impedire l’apertura del conflitto, che così rimane sottaciuto per paura di esporsi e di creare problemi, alimentando quell’atmosfera paludosa di cui parli, avviene anche, a mio avviso, il rischio che possa dilagare una sorta di relativismo pernicioso. Voglio dire che se non c’è apertura del conflitto ed elaborazione ragionata di certi temi, non si crea una via politica per i nostri rapporti all’interno di una rete di relazioni. Io considero la politica una forma per integrarmi nella società, un’integrazione che non è conformismo, ma è polemica, nel senso di visione critica di ciò che accade, mossa anche da una certa ansia per ciò che vorrei accadesse. Ciò che non mi va bene vorrei diventasse conflitto aperto, ma non strutturato per mera contrapposizione, un conflitto guidato da parole e azioni politiche efficaci. Io sento il desiderio di espormi, anche rischiando, se sento che qualcosa è vero.
Livia: “Tutti sono amici di tutti” mi suona incredibile. Perché, per esempio, la mia esperienza di partecipazione alla vita politica della città a Verona è che ci sia molta frammentazione e scarso desiderio di collaborare tra le varie realtà. La sensazione a Verona è che nessuno si conosca; c’è una solitudine tangibile, insostenibile a tratti, che mi sembra corrispondere, per la violenza che diffonde, all’aggressività a cui alludevi parlando di Napoli.
Sara: Anch’io ritengo che Verona sia una città molto frammentata. Ma penso che questa frammentazione non sia di per sé negativa. Ciò che è negativo è che a Verona si vengono a creare dei luoghi fecondi, fertili, anche dirompenti dal punto di vista politico, ma che purtroppo rimangano isolati tra loro, come se vivessero vite parallele, senza comunicare. Questo è il punto su cui per me occorre riflettere: perché non avviene una effettiva contaminazione politica fra queste realtà? Cosa è che impedisce la mancanza di interferenze?
All’ultima riunione di ADA Lab si è parlato anche di questo, di creare interferenze, per esempio tra le persone che si ritrovano per condividere la passione per la cultura vegana e il giro queer. Ciò che a me interessa far passare, ed è il punto più difficile, nemmeno alla “Corte” c’ero riuscita del tutto, è che questo posto, per chi condivide i principi dell’antisessismo, dell’antirazzismo e dell’antifascismo, è libero. ADA Lab vorrei fosse un posto in cui tutti possono sentirsi desiderosi di proporre qualcosa: un’iniziativa, un seminario sull’autogestione, su pratiche nuove, la semplice condivisione di esperienze e saperi, senza essere condizionati dal fatto che la casa mi appartiene legalmente. Che sia mia è sì una garanzia, ma solo in quanto la casa è di proprietà, e non c’è un affitto da pagare, cioè in quanto possiamo vivere una condizione più stabile, meno precaria.
Livia: Però il fatto che qui ci sia tu è una garanzia anche in un altro senso. Quando io sono arrivata qui ho sentito subito che era un posto aperto, e nello stesso tempo, per me, il fatto che fosse “tuo”, mi garantiva…
Sì, ti garantiva fiducia, perché evidentemente ti fidi di me. Sarebbe bello ci fossero tante altre persone, per cui ognuno si fida di qualcuno. A me interessa che ADA Lab venga percepito come spazio di riflessione, di elaborazione, in cui la fiducia nelle relazioni che nascono e le relazioni nuove che si creano siano il motore che alimenta questo luogo.
È piena estate, il gazebo ci ripara dalla luce troppo forte, ci godiamo l’orto. I pomodori giganti di tutte le sfumature dal verde al rosso, le zucche, il basilico, la rucola cresce a dismisura. Poco a poco iniziano ad arrivare altre persone con teglie, sacchetti, angurie, bottiglie.
è venerdì, e come tutti i venerdì, ad ADA Lab c’è la cena freegan (free + vegan). Il motto delle cene è: “Porta quello che vuoi trovare”. Una pratica anarchica e un’abitudine tra familiari reinvestita tra amic* e sconosciut*. La cena è ‘vegan’ perché non si mangiano prodotti di origine animale, ‘free’ perché la maggior parte del cibo è liberamente recuperato dai supermercati della zona. Ad ADA Lab si propone il recupero di cibi che in scadenza, o per preferibilità di scadenza, verrebbero gettati. Ogni giorno, infatti, chili di prodotti vengono gettati dall’industria alimentare perché non conformi alle leggi di vendita (una piccola ammaccatura, dimensioni non standard, ecc). Invece sul tavolo all’entrata di ADA Lab, un ragazzo dispone delle bottiglie di salsa preparata con i pomodori lasciati sui campi dopo la raccolta.
Contrastare lo spreco con le cene freegan si accompagna a pratiche di autoproduzione alimentari, che hanno fatto nascere, tra le persone che frequentano ADA Lab, il desiderio di realizzare un orto comunitario urbano. “A Vicenza si è formato un gruppo di persone che vuole realizzarlo. Da dove nasce questo desiderio? La crisi economica e la precarietà nel lavoro (quando ce l’abbiamo!) stanno portando a profondi cambiamenti negli stili di vita: sempre più persone riscoprono le pratiche di autoproduzione, dal fai-da-te al baratto, e questo interesse riguarda anche l’alimentazione. In città fioriscono orti sui balconi, laboratori che insegnano a fare il pane, cene e mercatini per scambiare ricette e riscoprire sapori dimenticati. Questo bisogno sotterraneo dovrebbe ora venire alla luce in modo pubblico, aprendosi alla città. Oggi il Comune concede degli orti ad associazioni di pensionati. Un’iniziativa lodevole, che però esclude tutta una fetta di cittadini, i giovani, i precari che probabilmente una pensione non la vedranno nemmeno, gli immigranti e tutte le categorie più colpite dalla crisi e che nella gestione comunitaria di uno spazio verde potrebbero trovare oltre che una parte del loro sostentamento materiale, anche un modo per creare relazioni, conoscersi, trovare nuovi modelli di vita in comune, riscoprire la solidarietà”11.
La via dell’apocalisse. Solo una catastrofe generalizzata potrebbe infatti ormai ricondurci alla condizione di indirizzare il progresso umano e tecnologico lungo strade diverse da quella imboccata con la rivoluzione industriale (…) Si può cedere alla tentazione di provare un senso di speranza, la speranza che qualcosa possa realmente accadere per arrestare la corsa letale e disumanizzante da cui stiamo venendo travolti e che dal crollo della matrice possano nascere nuovi frutti, autoprodotti con una nuova tecnologia, meno criptica e più libera. Passando dall’apocalisse e mettendo l’accento sul do-it-yourself, insomma, il punk a vapore può immaginare un mondo dove, per una volta, urlare « no future » non sia più strettamente necessario.
reginazabo
Note:
1. Elena Ferrante è lo pseudonimo di una scrittrice napoletana. In un passo di un’intervista, Ferrante parla così di Napoli: «Mi sono sentita diversa da questa Napoli, l’ho vissuta con repulsione, sono scappata via appena ho potuto, me la sono portata dietro come sintesi, un surrogato per tenete sempre a mente che la potenza della vita è lesa, umiliata da modalità ingiuste dell’esistenza. Da molto tempo, però, la guardo al microscopio. Isolo frammenti, ci scendo dentro, scopro cose buone che da ragazza non vedevo e altre che mi appaiono ancora più miserabili di allora», in Dietro la scrittura, Carteggio in forma di intervista e conversazione di Goffredo Fofi e Elena Ferrante.
2. Betty&books è uno shop-libreria online e corner shop che promuove la visibilità del piacere femminile (e non solo), la circolazione di saperi e conoscenze, di testi e libri d’arte selezionati con passione, da www.betty-books.com.
3. Per un punto di vista di genere sugli immaginari e le topografie del viaggio nella storia occidentale, cfr. Clifford, Culture in viaggio, in Strade, Bollati Boringhieri, Torino, 1999.
4. In questo slogan ci sembra implicito un punto di vista critico sull’invenzione del vibratore, che non è da considerare come un segno del riconoscimento sociale del piacere femminile, ma va inquadrato in un contesto storico culturale ben preciso. È la “società disciplinare” analizzata da Foucault che, dalla fine del XVII secolo, dà inizio alla cosiddetta modernizzazione della sessualità: il processo di isterizzazione del corpo femminile, una pedagogia sessuale dei bambini e delle bambine, la regolazione delle condotte di procreazione, la psichiatrizzazione dei piaceri perversi e l’affermazione della verità anatomica della differenza tra i sessi. Se da una parte si proibisce e controlla la masturbazione, dall’altra si medicalizza l’orgasmo femminile percepito come una crisi isterica, e si meccanicizza e addomestica l’orgasmo maschile attraverso la codificazione pornografica nascente. Il vibratore – inventato nella sua forma a vapore da George Herbert Taylor nel 1869 per curare l’isteria femminile, ed elettrico dal medico inglese Joseph Mortimer Granville per trattare dolori di origine nervosa negli uomini – è da annoverare dunque insieme “alle forme di architettura esteriori al corpo come quelle dell’asilo, della prigione e della caserma, i corsetti, lo speculum, la fotografia, il debutto della pornografia, le gestione del commercio sessuale dei bordelli metropolitani e coloniali, il controllo domestico dell’eterosessualità”, tra quelli che Beatriz Preciado nomina come elementi di una ‘orthopédie sexopolitique’, Beatriz Preciado, Histoire de la technosexualité, in Testo Junkie: sexe, drogue et biopolitique, Grasset, Paris, 2008, p. 70.
5. Ada Augusta Byron Lovelace (1815-1852), figlia legittima del poeta George Byron, incoraggiata dalla madre a non seguire le passioni del padre, intraprese studi scientifici, dedicandosi soprattutto alla matematica e al calcolo. Il suo pensiero è stato analitico e visionario, in un percorso in cui il linguaggio scientifico si nutriva costantemente di metafore e immaginazione.
6. reginazabo, Introduzione, in Margaret Killjoy, Guida steampunk all’apocalisse, traduzione e cura di reginazabo, Agenzia X, Milano 2008, p. 9.
8. Ursula Le Guin, Derrick Jensen, Margaret Killjoy, Miti e molotov, (a cura di M. Killjoy ), traduzione reginazabo, Collane di ruggine, 2010, p. 8.
9. Nella presentazione della collana si legge come il principio del D.I.Y (do it yourself) sia fondante per il progetto. “Tutto questo è facilitato dalla coproduzione, un metodo tutto interno al D.I.Y, che si sta diffondendo specialmente negli ultimi anni, e finora è rimasto legato quasi esclusivamente alle autoproduzioni musicali. Prima un gruppo si affidava a un’etichetta che curava in toto pubblicazione, distribuzione e promozione del disco, da qualche anno invece si manda in giro il proprio lavoro e si chiede a chi lo apprezza di unire le forze per produrlo. È evidente che in questo modo sarà più facile trovare i soldi necessari, ma i vantaggi non sono solo economici. Nel tempo si è creata una rete molto fitta di persone e progetti, una community (si direbbe in altri ambiti) tenuta insieme dalla voglia di produrre e veicolare dei contenuti, e dal desiderio di farlo da soli, senza il patrocinio o la supervisione di nessuno. Un disco prodotto in questo modo è un disco seguito e amato dall’inizio alla fine, un disco che già solo nella produzione è stato arricchito dalle energie di tutti quelli che lo hanno considerato interessante. Ecco noi abbiamo voluto provare ad applicare questo metodo anche ai libri, e non nascondiamo che il concetto che sta alla base vorremmo trovarlo in tutto quello che facciamo”.
10. reginazabo, in Margaret Killjoy, Guida steampunk all’apocalisse, p. 8.
11. Volantino sul tavolo di ingresso di ADA Lab.